Segnalazioni editoriali

Descrizione: Prima opera teatrale di Stefan Zweig, pubblicata a Lipsia nel 1907, la tragedia ambientata durante la guerra di Troia ha per protagonista un uomo ridicolo, debole, deforme, quasi mostruoso ma tanto più umano per la sua forza interiore: Tersite. Inascoltato ed emarginato da Achille e dagli altri guerrieri achei, primo fra tutti Ulisse, “il più brutto e il più vile dei Greci” va incontro al suo destino che prende le sembianze di Pentesilea/Teleia: prigioniera di Achille, la giovane rifiuta di essere barattata come trofeo di guerra per Patroclo e per via di un terribile equivoco giunge a designare proprio il fragile e claudicante Tersite come suo campione nello scontro con Achille. Ma è solo l’inizio dell’orrore e dell' inganno attraverso cui il protagonista scoprirà la propria unica, autentica forza: il dolore, conquista lucida della coscienza di sé. Nel finale, il riso tragico di Tersite fa del marginale personaggio iliadico un antieroe attuale, che attraversa il mito e giunge fino ai giorni nostri per interrogare il presente sulla vera natura del potere. Prima traduzione italiana del primo dramma in versi zweighiano, il testo è qui accompagnato da un saggio introduttivo di Arturo Larcati ed è seguito da una breve panoramica di Diana Battisti sulla lunga storia letteraria alle spalle del personaggio di Tersite.
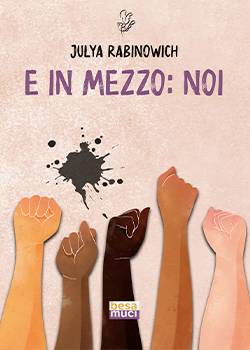
Link: https://www.besamucieditore.it/libro/e-in-mezzo-noi-julya-rabinowich/
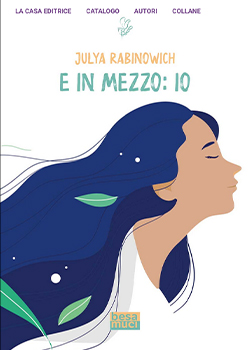
Link: https://www.besamucieditore.it/libro/e-in-mezzo-io-rabinowich/
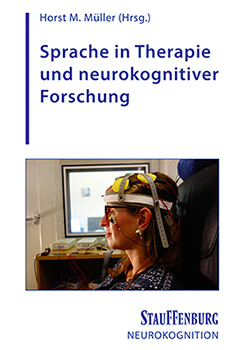
Descrizione: Müller, linguista e biologo, responsabile del Center for Cognitive Interaction Technology CITEC presso l’Università Bielefeld in Germania. La Linguistica Moderna è interdisciplinare, si è creato anche il ramo di Linguistica Applicata: si spiegano concretamente e empiricamente fenomeni dell’apprendimento della lingua infantile, il trattamento terapeutico di disturbi linguistici, la rappresentazione neuronale di processi di elaborazione linguistica nel cervello, aspetti che vengono trattati nel presente volume. Rientra in questo ampio spettro anche l’apprendimento delle seconde lingue. Müller è stato Visiting Professor all’Università di Padova e insieme a Winkler Pegoraro ha effettuato esperimenti con studenti dei corsi triennali e magistrali riguardo all’apprendimento della lingua tedesca in Italia: come risultato tra esperimenti effettuati e dati scientifici acquisiti dall’equipe di Müller è emersa l’importanza dell’interazione tra grammatica, prosodia, visualizzazione e Weltwissen.
Link: https://www.beck-shop.de/mueller-sprache-therapie-neurokognitiver-forschung/product/33068551
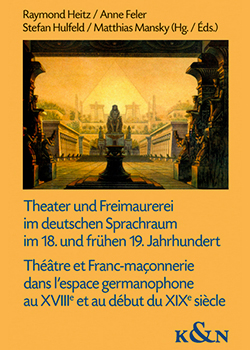
Descrizione: Die rasche Verbreitung der Freimaurerei im deutschen Sprachraum im 18. Jahrhundert blieb nicht ohne Auswirkungen auf das künstlerische, geistige und kulturelle Leben. Obwohl sich das Theater dabei als wirksames Medium erwies, hat die theatrale Behandlung der Freimaurerei in der Forschung nur mäßiges Interesse geweckt. Der vorliegende Band richtet den Fokus auf die Wechselwirkungen zwischen Dramenproduktion, Theaterleben und Freimaurerei in den deutschsprachigen Ländern im 18. und frühen 19. Jahrhundert. Berücksichtigt werden Symbolik, Rituale, historische und exotische Einkleidungen der Anliegen der Freimaurerei, deren Zielsetzungen und Wirken wie auch Kontroversen um ihre Rolle.
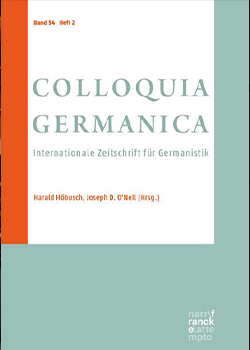
Descrizione: This special issue sets out to examine how literary discourses on justice have evolved in different historical and epistemological contexts. It seeks to define and assess how law is interpreted and applied in the texts, how the relations between law, society and power are outlined, and to what extent the staging of trials serves as a dramaturgic tool to comment on contemporary legal and judicial practices. The collected contributions offer in-depth textual analyses of exemplary courtroom dramas in historical and comparative perspective, as well as addressing more general aspects, such as the (a)symmetries between the dramatic urgency of legal processes and performance, the role of the spectator, the relations between fiction and reality, and the strategies with which theatre practitioners foster a reflection on societal issues and current political debates.
Contributors: Matthew Bell, Stefania Sbarra, Sophia Clark, Benedict Schofield, Laura Bradley, Benjamin Wihstutz, Daniele Vecchiato, and Richard McClelland.
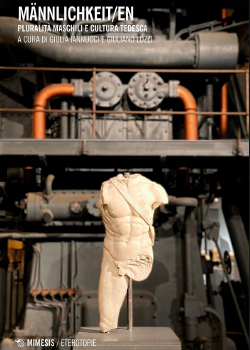
Descrizione: Perché oggi parliamo tanto di mascolinità? Il maschile, inteso come categoria discorsiva, è collocato dalla percezione odierna in uno stato di oscillazione costante: se da una parte viene messo in crisi il concetto di norma egemonica, dall'altra rimane in atto una tendenza che reitera le strutture patriarcali. Questo movimento trova riscontro nel contesto culturale tedesco che dall'età guglielmina conduce fino alla Repubblica di Weimar. In questo volume vengono messe in relazione le riflessioni scientifiche contemporanee e l'orizzonte culturale tedesco a cavallo tra Ottocento e Novecento, al fine di creare un inventario che racchiuda le declinazioni linguistiche, artistiche e storico-letterarie della Männlichkeit/en.
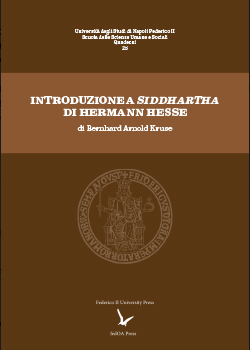
Descrizione: Siddhartha, il romanzo di Hermann Hesse del 1922, ha conosciuto una delle più ampie diffusioni a livello mondiale. Ambientato nell’India del V secolo a.C., questa storia di un ragazzo che contesta la casa paterna e la tradizione nella quale è cresciuto, e che ricerca la propria strada tra rovesciamenti completi della concezione dell’Io e del mondo, trova la sua attualità nei modelli di soggettività che propone ad una lettura tra empatia e distanza. La costruzione di nuove identità basate sull’interiorità tende a rafforzare il singolo che affronta la perdita di identità nelle moderne società industrializzate e organizzate dalle razionalità economiche, dove sperimenta l’estraniamento e l’isolamento nella società di massa che permea finanche le socialità digitali. La ricerca sincera e profonda del sé che conduce Siddhartha, fa sperimentare delle impostazioni della soggettività che nella lettura oltre alle figure e eventi narrati rafforza attraverso la struttura estetica la fiducia in se stessi e nella capacità di poter affrontare il futuro. L’analisi e l’interpretazione del testo in un procedimento di ‘close reading’, pensato anche, ma non solo per studenti agli inizi dello studio della germanistica, tentano di introdurre in questa dimensione del testo.
Link: http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/book/450
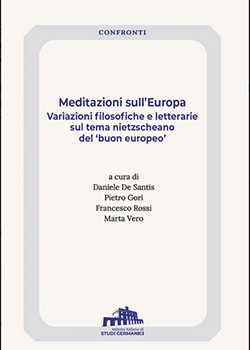
Descrizione: : Primo dei lavori sviluppati all’interno del progetto di ricerca Le radici mediterranee dello spirito europeo, il volume si inserisce nell’ampio dibattito sul concetto di Europa sviluppatosi negli ultimi decenni. Il suo obiettivo non è tanto di interrogarsi su «che cosa l’Europa sia» o pretenda essere, quanto piuttosto su una certa declinazione del modo d’essere europeo. I contributi qui raccolti esplorano la maniera in cui la figura del ‘buon europeo’ tratteggiata da Nietzsche in alcuni suoi scritti sia stata presa e ripresa, compresa e trasformata, impiegata o anche soltanto evocata da intellettuali, storici dell’arte, scrittori e filosofi attivi tra fine Ottocento e inizio Novecento. Ne emerge un quadro estremamente ricco di riflessioni che intersecano metodi e approcci di studio differenti.
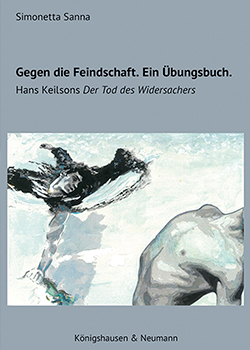
Inhalt: Dieses Übungsbuch ermöglicht es dem Leser, die Faszination der Feindschaft zu erkunden. Sein dialogischer Charakter leitet ermunternd dazu an, das Gelesene und die eigenen Erfahrungen immer wieder in Beziehung zueinander zu setzen. Die Literatur liefert so den Impuls für eine achtsame Art und Weise, mit sich selbst und den Mitmenschen umzugehen. Das entspricht der Differenziertheit unserer Selbstbeobachtung und unseres Weltverständnisses. Hans Keilsons Roman Der Tod des Widersachers ist dafür geradezu ein Musterbeispiel. Mitten im Krieg konzipiert, weist der junge jüdische Held die in der Luft liegende Besessenheit, ›Hie Freund – da Feind‹ zurück, obwohl sein Widersacher, eine B. genannte Figur, keinen Geringeren als Adolf Hitler in Person darstellt. Er verfolgt dessen Schicksal mit »Schwere und Erhabenheit« und ist überzeugt, dass der »Weg zu ihm und durch ihn hindurch zugleich der Weg« zu sich selbst sei. Da er diese Überzeugung unter den denkbar schlechtesten Umständen durchzuhalten vermag, zeigt der Roman auch die Möglichkeit an, Fremdidentifikation auch in anderen Zeiten und an anderen Orten einzulösen. Der Roman Der Tod des Widersachers liefert so ein Modell für postnationale Integrationsdiskurse und ein besseres Verständnis anderer Menschen und Kulturen.
Link: https://verlag.koenigshausen-neumann.de/product/9783826075360-gegen-die-feindschaft-ein-uebungsbuch/
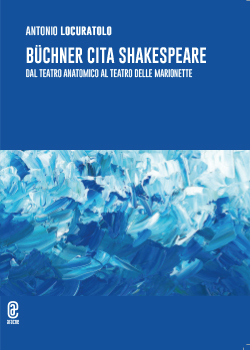
Descrizione: Büchner afferma che dinanzi alla storia e alla natura tutti gli scrittori «sono come scolaretti», tranne Shakespeare. La massiccia presenza di riferimenti a Julius Caesar e a Hamlet nel suo dramma storico Danton's Tod viene adoperata dall’autore per esporre la negatività del recupero della romanità in era rivoluzionaria. Il rapporto tra Leonce e il buffone Valerio nella sua commedia Leonce und Lena riflette, invece, quello tra il malinconico Jaques e il fool Pietraccia in As You Like It, ponendosi come scopo precipuo la decostruzione di un genere volto a occultare ogni aspetto materiale della vita. Entrambi gli autori restituiscono al corpo una nuova centralità, ritrovando nel Witz quel linguaggio che annulla ogni differenza e smaschera in maniera dissacrante la realtà, dando voce anche alla «gente più prosaica di questo mondo».
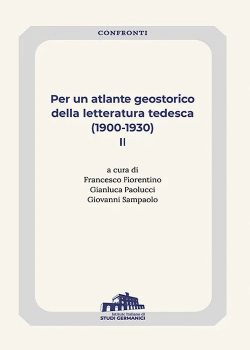
Descrizione: Un Atlante geostorico che racconta la letteratura dei paesi di lingua tedesca a partire da luoghi, spazi e pratiche spaziali che hanno agito come catalizzatori dell’immaginario letterario, favorendo la produzione di testi, stili, motivi, metafore: da questo progetto nascono i saggi raccolti in questo volume, dedicati a luoghi diversi come la Praga espressionista e l’industria discografica Carl Lindström, Alexanderplatz e gli hotel della Svizzera, la rivista «Der Brenner» e la Galizia, la Berlino queer, l’incendio del Palazzo di Giustizia a Vienna o la clinica psichiatrica di Waldau.
Link: https://www.studigermanici.it/per-un-atlante-geostorico-della-letteratura-tedesca-ii/
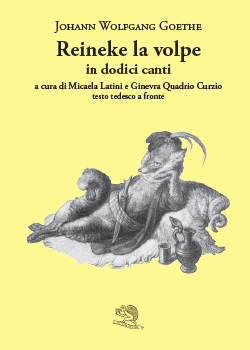
Descrizione: Composto da Goethe tra il 1793 e il 1794 durante l’assedio di Magonza cui il granduca di Sachsen-Weimar-Eisenach partecipava come membro della coalizione antifrancese, il Reineke Fuchs è la rielaborazione in esametri (il verso dell’epica omerica) delle avventure della volpe e della sua inimicizia con il lupo, un soggetto letterario di grandissimo successo a partire dalle sue prime versioni nell’Ysengrimus di Nivardo di Gand (1150 circa) e poi nelle branches del Roman de Renart a opera di diversi trovieri tra il XII e il XIII secolo. In queste movimentate e mirabolanti vicissitudini picaresche con protagonisti animali, che con spirito irriverente, anarchico e carnevalesco mettono a nudo una scomoda verità riguardo ai rapporti sociali tra uomini cosiddetti “civilizzati”, Goethe trova quella che definisce una «Bibbia empia del mondo». È un modo leggero e giocoso di prendere le distanze dalla violenza e dai cataclismi politici che l’Europa si trova a vivere negli anni della Rivoluzione francese. Oltre che una satira impietosa dei vizi della società di corte, i versi trascinanti dell’epos della volpe Reineke sono una lettura appassionante, ricca di emozioni e colpi di scena.
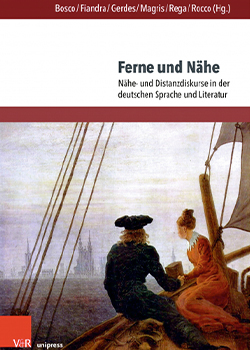
Descrizione: In letzter Zeit haben Ferne und Nähe mit den ihnen verwandten semantischen Konzepten (z.B. Weite, Fremdheit, Entfernung, Fernweh, Aus- und Entgrenzung, Andersheit, Heimweh, Nostalgie, Grenze, Beschränkung gegenüber Verbundenheit, Vertrautheit, Nachbarschaft, Verwandtschaft, Sympathie, Empathie) zunehmend an Bedeutung und Aktualität gewonnen – und dies nicht zuletzt auch aufgrund der durch die Corona-Pandemie weltweit ausgelösten Krise. Im vorliegenden Band wurden einschlägige Beiträge italienischer und deutscher Literatur- und Sprachwissenschaftler:innen mit dem Ziel zusammengestellt, ein neues Kompendium zu den literarischen und sprachlichen Ausdrucksformen der Empathie und Distanz, zu den Ein- und Ausschlussverfahren in Literatur und Sprache, zur Treue oder Verfremdung in Literatur, Übersetzung und Sprachdidaktik sowie zu den Versprachlichungs- und Literarisierungsformen von Nähe und Distanz bereitzustellen.

Descrizione: L’Ifigenia in Tauride di Goethe indaga l’impulso profondo che diede vita a uno dei drammi goethiani più incompresi al momento della loro genesi e più discussi dalla critica letteraria e filosofica novecentesca, da un lato ricostruendo la creazione dell’opera, non solo dentro i contesti specificamente goethiani, ma anche all’interno del più generale ambito filosofico-politico giusnaturalistico e illuministico; dall’altro, ripercorrendo la sua “maturità postuma”, attraverso le lenti di studiosi come Theodor W. Adorno e Walter Benjamin, nonché dei principali teorici dell’estetica sacrificale.
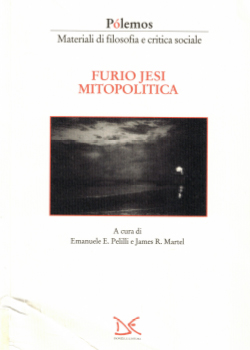
Descrizione: Il volume è dedicato alla figura del germanista e studioso torinese scomparso precocemente nel 1980 e ripercorre criticamente una serie di problematiche e figure da lui affrontate nel corso degli anni, prefiggendosi di “contribuire ad attualizzare i nuclei incandescenti del suo pensiero” in un presente in cui “l’ascesa delle destre e dei populismi, la performatività delle narrazioni e dei discorsi, il richiamo al passato e a valori eterni come legittimazione del presente” si stanno manifestando “nella loro brutale concretezza”.
Link: https://www.rivistapolemos.it/issue/furio-jesi-mitopolitica/?lang=it
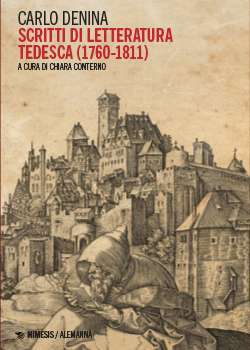
Descrizione: Nei suoi appunti del viaggio in Italia (1775) Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) annota che “anche gli italiani non hanno tralasciato di occuparsi della recente letteratura tedesca” e porta come primo esempio Carlo Denina (1731-1813). Mezzo secolo separa le scarse notizie contenute in Della Letteratura Tedesca, nella prima edizione del Discorso sopra le vicende della letteratura (1760), dalla Doppia rivoluzione della letteratura tedesca nel Saggio istorico-critico sopra le ultime vicende della letteratura (1811). In questo percorso spicca l’edizione berlinese del Discorso (1784-1785) che rappresenta una maturazione significativa, sia sul piano della struttura sia su quello del contenuto, di un testo sorto quasi 25 anni prima. Nel suo approccio sincronico e inclusivo delle manifestazioni letterarie europee Denina riserva un’attenzione maggiore alla letteratura tedesca che viene qui rappresentata da più autori, autrici e opere. Il volumetto raccoglie i testi dedicati da Denina alla letteratura tedesca nelle edizioni delle Vicende susseguitesi a partire dal 1760 e aggiunge quello contenuto nel Saggio istorico-critico (1811). La postfazione dà conto della loro specificità, in particolare dell’ampliamento di conoscenze e del cambio di approccio dopo il trasferimento di Denina a Berlino.
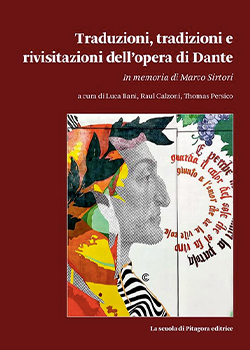
Descrizione: A poco più di un anno di distanza dalla chiusura del Progetto UniBg per Dante 2021, vede le stampe questa raccolta di studi in Open Access e in formato cartaceo, che riunisce i contributi scientifici di molti dei circa 100 partecipanti all'omonimo Convegno internazionale del maggio 2021, organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli studi di Bergamo. Le tre parti che compongono la silloge rispecchiano la trina suddivisione dei lavori: Teorie e metodi per la traduzione dantesca, Dante e i commenti e Rivisitazioni e fortuna dell’opera di Dante. Questo volume è dedicato alla memoria di Marco Sirtori, che molte energie aveva profuso per il progetto dantesco.
Link: https://www.scuoladipitagora.it/libreria/traduzioni,-tradizioni-e-rivisitazioni-dell-opera-di-dante
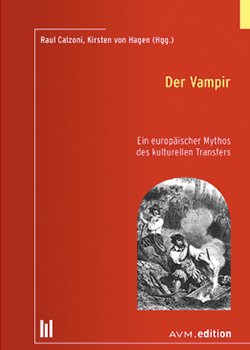
Beschreibung: Der Vampirmythos findet in der Populärkultur als Blutsauger und Übermensch Resonanz. Es geht um die rätselhafte Frage des Übergangs der Toten ins Jenseits, das Spannungsfeld von Eros und Thanatos. Seit mehr als 200 Jahren nach der Veröffentlichung von John Polidoris The Vampyre. A Tale (1819) ist der Vampir Bestandteil der europäischen Literaturen. Als liminale Figur konnotiert er Invasion und ist damit eng mit der Abwehr des (fremden) Anderen assoziiert; als ambivalente Figur signifiziert der Vampir faszinosum und tremendum, steht für Kulturkontakt und Abgrenzung gleichermaßen. Der Vampir fungiert seit der Aufklärung selbst als Reflexionsfigur unterschiedlicher Wissenskulturen und ist derart für die Fragestellung des kulturellen Transfers doppelt relevant. Insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen in Europa mit gegenwärtig einhergehender Angst vor Überfremdung entwickelt die Figur neues Deutungspotential. Die Grenze zwischen Tier und Mensch, belebt/unbelebt, dem Heiligen und dem Profanen, zwischen Genres und Medien, zwischen Kulturen, gesellschaftlichen Schichten, Geschlechtern, geographischen Räumen – all diese Aspekte thematisiert dieser Band am Beispiel der Grenzgängerfigur Vampir. Mit Beiträgen von: Raul Calzoni, Maria Grazia Cammarota, Silvia Casazza, Michela Gardini, Kirsten von Hagen, Peter von Möllendorff, Alexandra Müller, Marco Sirtori, Martin Spies, Bernhard Unterholzner, Alessandra Violi
Link: https://www.avm-verlag.de/detailview?no=L95477155&fbclid=IwAR3FFbLfY-
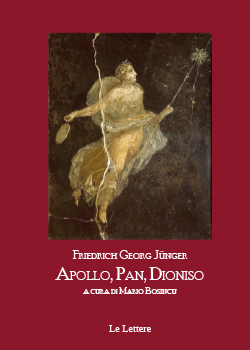
Descrizione: Germania, 1943: nel cuore del Terzo Reich Friedrich Georg Jünger pubblica uno studio su Apollo, Pan e Dioniso che eserciterà un’influenza decisiva sul fratello Ernst. “Da tempo mio fratello Friedrich Georg ed io”, scriverà, infatti, Ernst Jünger nel 1982, “ci siamo occupati, sia soffrendone che essendone spettatori, del ritirarsi degli dèi e dell’avvento dei titani”. Anticipando gli esiti delle ricerche di Hillman, Friedrich Georg Jünger mostra come l’uomo moderno sia un soggetto ‘mitopatico’ che soffre l’azione degli dèi e che ripete lo schema del loro agire. Ecco, allora, che “l’epoca della pianificazione razionale che vorrebbe abbracciare e racchiudere tutto” è ricondotta all’azione intrapsichica di Prometeo, il modello dell’homo faber nazista e della sua hybris tecnologica che viola e saccheggia la natura. Tracciando una fenomenologia di tre archetipi divini, Apollo, Pan e Dioniso, lo scrittore assume, quindi, un ruolo guida. Il suo compito è additare ai lettori la via della loro integrazione psichica al fine di liberarli dalla forma di soggettività fanatica, tecnolatrica, distruttiva e sofferente dominante nella Germania hitleriana – e nella nostra contemporaneità – e di dischiudere loro l’accesso a stili esistenziali alternativi. Si profila, così, l’ideale di un soggetto capace di contemplazione apollinea, pieno di timore reverenziale per la Madre Terra ed in grado di vibrare all’unisono con la Vita. Poiché “dionisiaco è il traboccare del calice e lo spezzarsi del vetro”.