Segnalazioni editoriali
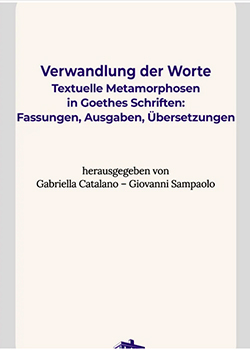
Beschreibung: Ausgehend von Goethes morphologischen Konzepten der Gestalt und der Verwandlung untersucht dieser Band dessen literarisches Schaffen auf den Ebenen der Entstehungsstufen und Fassungen, Editionen der eigenen Werke und Übersetzungen fremder Texte als Aspekte einer umfassenden Wortmetamorphose. Bildung und Umbildung charakterisieren sein Werk. Das Gestaltungspotenzial stellt aber das Abgeschlossene und Statische in Frage und macht letztendlich das goethesche Organismusdenken selbst problematisch. Zufall, Nebeneinander und Diskontinuität bestimmen die Entstehung der Texte und das ständige Ineinanderübergehen ihrer Elemente und Formen als überaus modernes Spiel unterschiedlicher Interferenzen und Verschiebungen.

Descrizione: Thomas Mann, Stefan Zweig e Hermann Hesse: sono solo tre degli autori chiave del Novecento che devono il loro successo in Italia ad una intraprendente consulente mondadoriana di nome Lavinia Mazzucchetti (1889-1965). Germanista per passione e traduttrice per necessità, la sua biografia ripercorre le tappe di un percorso personale e professionale emblematico per una donna intellettuale del secolo scorso. La perdita dell’incarico universitario e della cattedra scolastica a causa del suo antifascismo determina il suo approdo al mondo editoriale e la scoperta della letteratura tedesca contemporanea. L’ambizione di far conoscere, e amare, al pubblico italiano gli autori da lei prediletti caratterizza fin dall’esordio la sua attività di mediatrice, curatrice e traduttrice. Dallo studio del materiale archivistico, in particolare della corrispondenza con alcune tra le figure che più hanno segnato il loro tempo – da Benedetto Croce a Giovanni Gentile –, e dei numerosissimi saggi pubblicati in periodici e poi raccolti in volume, emerge una fede incrollabile nella letteratura come strumento di dialogo e di mezzo imprescindibile per migliorare l’uomo.
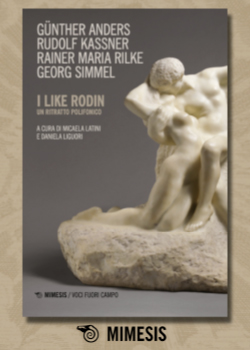
Descrizione: Auguste Rodin è universalmente considerato il progenitore della scultura moderna. In questo libro sono presentati quattro studi a firma di altrettanti autori di ambito linguistico tedesco del Novecento: Günther Anders, Rudolf Kassner, Rainer Maria Rilke e Georg Simmel. Tra appunti, testi di conferenze e saggi viene indagata la fortuna della scultura di Rodin nella cultura letteraria e filosofica, mettendo in un luce una stratificata rete di somiglianze e differenze nelle diverse letture offerte. Le tessere di cui si compone il volume compongono dunque due differenti mosaici: da una parte la restituzione di un’immagine nitida e sorprendentemente attuale di Rodin, dall’altra la scoperta delle assonanze tra Anders, Kassner, Rilke, e Simmel.
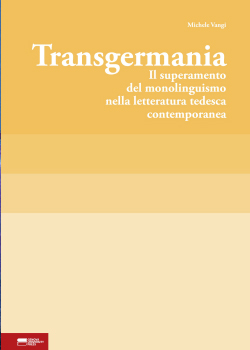
Descrizione: la scrittura plurilingue implica spesso una riflessione metalinguistica che fa emergere, da un lato, l’impossibilità di stabilire equivalenze e, dall’altro lato, la possibilità di coabitazione nello stesso testo di sensibilità linguistiche differenti, in un’ottica che in questo studio si definisce translinguistica. Autrici e autori di origine ebraica che scrivono in tedesco, giunti in Germania dall’Europa postsovietica negli anni ‘90: questo il campo letterario di riferimento del volume. In particolare, ci si sofferma sulle opere di Katja Petrowskaja, Olga Grjasnowa e Sasha Marianna Salzmann. Alla galassia transculturale a cui essi afferiscono si è dato il nome simbolico di ‘Transgermania’. Questi testi rivelano infatti un nuovo immaginario del paese: sempre più multilingue e sempre meno legato al monopolio dei parlanti ‘nativi’ sulla lingua tedesca. Centrali sono nell’analisi: la rielaborazione dell’esperienza dell’emigrazione, il rapporto con l’ebraismo – in particolare dalla prospettiva femminile – e gli approcci generazionali differenti al tema dell’identità.
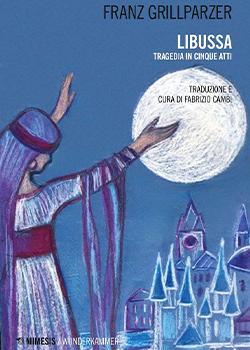
Descrizione: Un classico della letteratura tedesca, Libussa di Franz Grillparzer, viene pubblicato per la prima volta in traduzione italiana nella collana Wunderkammer (Mimesis, Milano). Nella tragedia prende vita la figura leggendaria della fondatrice della dinastia ceco-boema dei Přemyslidi e della stessa città di Praga. La più giovane delle figlie del condottiero Krokus, vive il conflitto interiore fra mondo arcaico, radicato nelle leggi di natura e nella magia, e modernità, soccombendo al dissidio fra spirito contemplativo e azione richiesta dall’incalzare degli eventi. Questa figura, ricca di umanità ed empatia, è l’ultima grande rappresentante di un matriarcato rurale, che soccombe alle istanze della civiltà urbanizzata voluta dagli uomini del suo popolo, dedito ai commerci e al progresso. Fra apocalissi e palingenesi, Libussa incarna le istanze utopiche di una riconciliazione del dissidio fra conoscenza e azione nei valori del sentimento, sperando di arginare così i più nefasti esiti della modernità tecnologica e disumanizzante. La traduzione e la curatela di questo volume, ricco di un minuzioso e illuminante apparato di commenti, costituiscono l’ultima opera dell’illustre germanista Fabrizio Cambi, scomparso nel 2021.

Descrizione: L’età romantica ha inciso profondamente sulla concezione moderna dell’arte e della letteratura, sia in relazione al modo di intendere il rapporto tra fantasia e realtà, sia per quanto riguarda la rielaborazione dei miti e dei modelli tradizionali. È l’età in cui gli sviluppi dei saperi scientifici e filosofici si intrecciano con i più radicali mutamenti nella vita sociale, politica ed economica, mentre esplode la questione nazionale: Rivoluzione e Restaurazione sono i poli cronologici e dialettici che la comprendono, e tuttavia la sua eredità ci riguarda ancora oggi. Il volume si addentra nel laboratorio poetico e sociale del Romanticismo tedesco, tracciandone un bilancio attraverso l’analisi delle opere e del dibattito intellettuale da cui deriva il suo ruolo di avanguardia nella storia culturale dell’Europa contemporanea. La concezione ironica, universale e progressiva della scrittura inaugurata dai romantici tedeschi conferisce infatti un rilievo inedito ai dispositivi di mediazione letteraria, tra i quali rientrano la critica, la traduzione e la riscrittura.

Descrizione: In letzter Zeit haben Ferne und Nähe mit den ihnen verwandten semantischen Konzepten (z.B. Weite, Fremdheit, Entfernung, Fernweh, Aus- und Entgrenzung, Andersheit, Heimweh, Nostalgie, Grenze, Beschränkung gegenüber Verbundenheit, Vertrautheit, Nachbarschaft, Verwandtschaft, Sympathie, Empathie) zunehmend an Bedeutung und Aktualität gewonnen – und dies nicht zuletzt auch aufgrund der durch die Corona-Pandemie weltweit ausgelösten Krise. Im vorliegenden Band wurden einschlägige Beiträge italienischer und deutscher Literatur- und Sprachwissenschaftler:innen mit dem Ziel zusammengestellt, ein neues Kompendium zu den literarischen und sprachlichen Ausdrucksformen der Empathie und Distanz, zu den Ein- und Ausschlussverfahren in Literatur und Sprache, zur Treue oder Verfremdung in Literatur, Übersetzung und Sprachdidaktik sowie zu den Versprachlichungs- und Literarisierungsformen von Nähe und Distanz bereitzustellen.

Descrizione: Das Internet in seiner Allgegenwart hat unsere Art und Weise, wie wir interagieren, verändert. So laden Computer, Tablet und Smartphone kreativ dazu ein, Texte mit Bildern, Videos und Memes zu ergänzen. Hybride Kommunikationsstrategien sind an der Tagesordnung: Um unmittelbar, authentisch und eindeutig zu kommunizieren, bereichern die Nutzer der digitalen Weltgeschriebene und gesprochene Texte um weitere Elemente zu multimodalen und multimedialen Formen. Die so erschaffenen neuen Ebenen von Referenzialität, Intertextualität und Transmedialität verlangen nach adäquaten Kriterien für die Analyse der Beziehung von Text und Bild. Silvia Verdiani liefert genau das. An repräsentativen Beispielen aus dem politischen Online-Diskurs von NGOs untersucht sie die syntaktisch-funktionalen Implikationen der Verwendung hybrider Kommunikation. Sie zeigt zudem, wie genau die semantische Kombination von verbaler und ikonischer Sprache wirkt, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Descrizione: Il libro esplora i Pronominaladverbien tedeschi, proponendone una descrizione morfologica, semantica e sintattica. L’analisi empirica di corpora scritti e orali si concentra su cinque avverbi pronominali il cui primo costituente è da(r)−. Lo studio dei dati di tedesco lascia spazio ad un’indagine contrastiva con l’italiano. Gli usi e i comportamenti dei Pronominaladverbien sono messi a confronto con quelli di forme morfologicamente simili dell’italiano, al fine di verificare se l’italiano presenti una categoria grammaticale analoga o simile agli avverbi pronominali. A conclusione del lavoro, un’analisi che privilegia l’approccio traduttivo conferma i risultati dello studio interlinguistico e rivela i mezzi e le strutture a cui ricorre l’italiano per la resa dei Pronominaladverbien.

Descrizione: Nato da un seminario interdisciplinare organizzato per le studentesse e gli studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna, il volume Exchanges, Intersections and Gender Issues between Eighteenth and Nineteenth Century Europe: The Anglo-German Case / Kulturtransfer, Verschränkungen und Gender-Fragen in Europa zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert: der deutsch-britische Fall si concentra su alcuni significativi scambi culturali tra Regno Unito e Germania, contatti produttivi che hanno avviato un inevitabile processo di cambiamenti e innovazioni nella letteratura e nella cultura del XVIII e XIX secolo in entrambi i contesti e in diversi settori: dall’antropologia e dal transfer culturale passando per l’analisi filologica, fino alla prassi traduttiva.

Descrizione: Il volume raccoglie gli esiti scientifici delle lezioni del primo Master di I livello in Didattica della lingua tedesca come LS-L2, tenutosi presso l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa nell’anno accademico 2020/21, e riflessioni scientifiche e didattiche che rispondono in maniera critica alle esigenze di rinnovamento degli impianti concettuali dei programmi scolastici ministeriali. Il volume si configura altresì come un manuale per la preparazione di concorsi per la scuola secondaria di I e II grado, dell’abilitazione per il sostegno linguistico in tedesco nelle scuole in lingua tedesca per alunne e alunni con sfondo migratorio e, non ultimo, per la formazione continua dei docenti di lingua e civiltà tedesca. Contributi di Balbiani, Ballestracci, Corrado, Fiorentino, Hepp, Hoffmann, Malloggi, Missaglia, Moraldo, Nied, Paumgardhen, Russo, Sirignano.
Link: https://mimesisjournals.com/ojs/index.php/kritik/issue/view/102

Descrizione: Intellettuale antiaccademico ed eccentrico, Günther Anders è autore di una irriverente “antropologia” nella quale la locuzione “dislivello prometeico” indica lo iato al centro del concetto di “uomo antiquato”. L’indagine sulla condizione dell’uomo nell’era della tecnocrazia mette a nudo il dramma di una contemporaneità profondamente segnata al suo interno dall’asincronia tra evoluzione organica e sviluppo tecnologico.

Descrizione: Questo volume rappresenta una lettura importante per chi voglia scoprire le origini della svolta copernicana della filosofia occidentale in senso antropologico e conoscere le più importanti tappe dello sviluppo dell’estetica del Settecento tedesco. Nel “laboratorio della modernità” di Herder si attua un rinnovamento radicale del sistema dei saperi; esso implica un accurato confronto con i maggiori pensatori e scrittori europei, protagonisti di una lunga stagione che va dal Rinascimento al tardo Illuminismo. I dodici saggi presentati nel volume, introdotti e commentati, mostrano lo sviluppo originario del pensiero critico herderiano in campo filosofico, estetico-letterario e storico-politico. Troviamo qui le fondamenta delle sue opere più corpose, cioè Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità e Idee per la filosofia della storia dell’umanità. Gli scritti qui raccolti interessano gli anni tra il 1765 e il 1787 e si coagulano intorno all’urgenza della formazione di un gusto e di un’opinione pubblica, forti per il presente come per il futuro. Viene dato particolare risalto all’incontro di Herder con Goethe, che fu risolutivo per la redazione finale del capolavoro del 1778, cioè la Plastica, vero manifesto della nuova estetica empirica dell’Illuminismo.
Link: https://www.bompiani.it/autori/johann-gottfried-von-herder-13105

Descrizione: «Auf Wiedersehen in Florenz!» Voci di ebrei tedeschi dall’Italia presenta uno spaccato della Exilliteratur tedesca i cui protagonisti emigrarono a Firenze dopo l’avvento del nazionalsocialismo. Oltre a ricostruire il contesto della città negli anni 1933-1938, il volume esplora anche la produzione di alcuni autori e autrici dell’esilio, protagonisti del fervente clima culturale che si diffuse a Firenze grazie all’intersezione tra le culture tedesca, ebraica e italiana. Tra gli esponenti di questo contesto letterario, vi è un gruppo di autori che compare nella sezione dedicata alla scrittura in esilio (Alice Berend, Rudolf Borchardt, Karl Wolfskehl e Walter Hasenclever) mentre un altro gruppo compone, invece, il nucleo del post-esilio (Max Krell, Monika Mann, Otti Binswanger-Lilienthal e Georg Strauss).
Link: https://www.fupress.com/it/news/auf-wiedersehen-in-florenz/10255

Descrizione: A partire dagli anni Novanta del Novecento il Linguistic Landscape (LL) è stato oggetto e strumento della ricerca linguistica applicata a una specifica area geografica antropizzata, inizialmente rappresentata soprattutto da città, grandi e piccole. Questo lavoro intende offrire una nuova prospettiva di lettura del ‘paesaggio linguistico’, focalizzando l’attenzione sull’unità geografica costituita da una valle e da tutto ciò che ne fa parte: dalle città ai paesini, dalle strade provinciali ai sentieri, dai laghi ai boschi, dagli alberghi ai rifugi di alta montagna. L’area oggetto della ricerca sono le quattro valli principali e alcune valli trasversali dell’Alto Adige/Südtirol, la cui complessa situazione storico-politica ne condiziona e determina il relativo paesaggio linguistico.

Descrizione: L’opera di Christa Wolf (1929-2011) può essere vista come una grande operazione di recupero della memoria culturale, storica e personale. Da una parte, ripercorre le tappe fondamentali della storia contemporanea tedesca, dalla Seconda guerra mondiale all’esperienza della DDR fino alla riunificazione e alla disfatta del progetto socialista. Dall’altra, ricostruisce l’identità culturale presente, collettiva e individuale, tramite la rilettura e la riscrittura dell’antico – della mitologia greca e del Romanticismo tedesco. Ci restituisce così una visione della cultura e dell’identità come dimensioni dinamiche e multiformi, che possono definirsi solo attraverso il contatto con l’altro, il diverso, il rimosso. È da questa suggestione che si sviluppano i percorsi di lettura contenuti nel presente volume, nuove chiavi interpretative per comprendere la scrittura di quella che è considerata la massima rappresentante della letteratura tedesco-orientale. Con testi di: Ulrike Böhmel Fichera, Rita Calabrese, Anna Chiarloni, Gaia D'Elia, Antonella Gargano, Annett Gröschner, Gabriele Guerra, Giulia Iannucci, Daniela Padularosa, Massimo Palma, Paola Paumgardhen, Anita Raja.
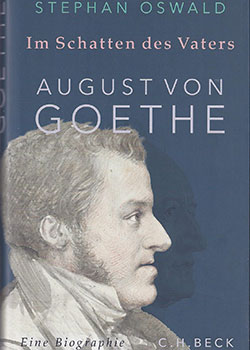
Beschreibung: August von Goethe fristet in der allgemeinen Wahrnehmung ein trauriges Dasein als Sohn seines berühmten Vaters und schwarzes Schaf der Familie. Stephan Oswald erzählt seine Geschichte erstmals aus seiner eigenen Perspektive. Gestützt auf zahlreiche unbekannte Quellen, macht er einen ganz anderen Menschen sichtbar und eröffnet zugleich einen intimen Einblick in das Leben am Frauenplan und die Verhältnisse im klassischen Weimar. Entgegen der landläufigen Überzeugung hat August auch eigene literarische Versuche unternommen. Die erhaltenen Fragmente werden hier erstmals veröffentlicht.
Link: https://www.chbeck.de/oswald-schatten-vaters/product/33759460

Descrizione: Nato a Krefeld ma berlinese d’adozione, Ulrich Peltzer (1956) è autore di sette romanzi e di numerosi saggi teorici. La collocazione editoriale e la ricezione della sua opera, insignita di molteplici premi, ne attestano la rilevanza artistica e intellettuale, alla quale non corrisponde però una commisurata produzione di studi critico-letterari, anzi del tutto assenti nella germanistica italiana. Al fine di colmare tale lacuna, questa monografia propone un inquadramento ragionato della scrittura di Peltzer nel contesto della letteratura contemporanea e, al contempo, un confronto con la tradizione novecentesca. La verifica delle strategie estetiche di Peltzer e l’analisi dei suoi romanzi Bryant Park (2002) e Teil der Lösung (2007) legittimano la scelta della metropoli come oggetto del discorso critico e lente prospettica. In quanto spazio fenomenologico del moderno, la metropoli favorisce una riflessione transdisciplinare sui mutamenti culturali, sociali e urbanistici del presente: in particolare, sulla rideterminazione dei rapporti tra soggetto e potere entro un sistema intrinsecamente totalitario, qui definito città totale.

Descrizione:I saggi contenuti in questo volume sono il frutto di ricerche svolte nell’ambito dell’omonimo progetto, finanziato dall’IISG. Obiettivo del progetto è una mappatura dei luoghi dell’Israelkorpus – una raccolta di interviste biografico-narrative a israeliani emigrati da aree tedescofone in Palestina/Israele soprattutto negli anni Trenta – indagando i luoghi non tanto in quanto tali, ma alla luce della loro funzione all’interno dell’elaborazione mnestica e narrativa nelle interviste, che è quindi legata anche alla dimensione emotiva. I contributi qui raccolti, di taglio inter- e transdisciplinare, sviluppano diversi approcci degli studi linguistici, storici e culturali, con particolare attenzione alle prospettive dell’analisi della conversazione, della narratologia e della storia orale. Illustrando esperienze di vita di esponenti dell’ebraismo tedescofono costretti all’emigrazione, le analisi contribuiscono in modo significativo alla ricostruzione di quel contesto, che rappresenta una parte importante della storia europea e un capitolo significativo della storia delle migrazioni del XX secolo.

Descrizione e contributi: Almeno a partire dall’inizio degli anni Sessanta, la riflessione e le indagini sulla Shoah si sono giustamente concentrate soprattutto sulle vittime e quindi sui testimoni delle persecuzioni e dello sterminio. L’ottantesima ricorrenza il 20 gennaio 2022 del famoso e famigerato incontro presso la villa sul Wannsee, a sud-ovest di Berlino, in cui venne deliberata la Soluzione finale, suggerisce tuttavia un cambio almeno parziale di prospettiva, che metta a fuoco anche gli autori, vale a dire i perpetratori di quel crimine. Nella storiografia, un simile mutamento di paradigma ha avuto inizio già a partire dagli anni Novanta, quando una serie di importanti ricerche hanno cominciato a indagare non solo o non tanto le figure dei principali gerarchi e criminali nazisti, bensì anche le centinaia di migliaia di ‘uomini qualunque’, di giuristi, funzionari, burocrati, di semplici cittadini, studenti, lavoratori e buoni padri di famiglia che in diversi ruoli e con diverse modalità hanno preso parte attiva al più grande crimine dell’umanità. I contributi contenuti in questo volume intendono portare avanti queste ricerche e approfondire, in particolare, le diverse rappresentazioni dei perpetratori presenti nella letteratura, nel cinema o in altri media, per interrogarsi anche sull’evoluzione di tali raffigurazioni, che costituiscono l’espressione più immediata di quell’immaginario collettivo che esse stesse contribuiscono a formare.