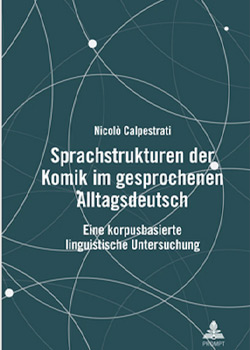Segnalazioni editoriali
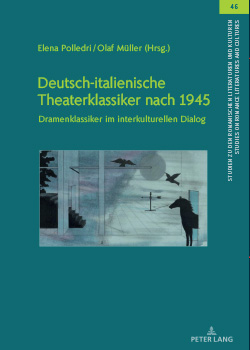
Descrizione: Wie wurden Klassiker wie Schiller, Goethe Kleist, Büchner, Kafka, Brecht und Handke in Italien, z. B. von Dichtern wie Edoardo Sanguineti und Dramaturgen wie Cesare Lievi, übersetzt und auf den italienischen Bühnen aufgeführt? Wie wurden Goldoni, Fausto Paravidino oder Stefano Massini im deutschsprachigen Theater rezipiert und inszeniert? Der vorliegende Band beleuchtet durch paradigmatische Fallstudien erstmals eingehend den wechselseitigen Austausch in den deutsch-italienischen Theaterverhältnissen von 1945 bis in die Gegenwart mit einem besonderen Augenmerk auf den Übersetzungen und der Aufführungspraxis in ihrem jeweiligen Zusammenspiel. Die Untersuchung der Rezeption der deutschen Dramatiker in Italien und der italienischen in Deutschland erfolgt aus der Perspektive eines europäischen Theaters und einer dramatischen ‚Weltliteratur‘.

Descrizione: Il volume raccoglie i risultati delle ricerche condotte dall’autrice sulla figura di Felix Dahn (1834- 1912), professore di discipline giuridiche e di storia del diritto nella Germania bismarckiana e guglielmina, ma soprattutto autore di successo di romanzi storici, la cui enorme fortuna contribuì a diffondere e a rendere popolare un Germanesimo tragico-eroico, fatale per la corrosione di ogni principio di umanità, con ripercussioni infauste sulla formazione di intere generazioni di giovani Tedeschi fino alla Seconda Guerra mondiale. L’autrice ricostruisce le origini del mito germanico nell’opera di Dahn attraverso una approfondita indagine biografica che mette in luce gli intrecci tra la vicenda personale dello scrittore e la storia culturale e politica del suo tempo, attingendo per la prima volta a una ricchissima documentazione inedita, costituita in particolare dalla corrispondenza familiare e dalle lettere di amici e colleghi, custodite presso la Biblioteca Nazionale Bavarese e l’Archivio Centrale di Stato di Monaco, finora mai utilizzate dagli studiosi.

Descrizione: Wie reagieren Autorinnen und Autoren der Gegenwartsliteratur auf die Spannungen und Widersprüche des heutigen euromediterranen Raums, angesichts multipler Krisen und Bedrohungsszenarien? Wie setzen sie Politik, gesellschaftlichen Wandel und Fragen des individuellen und kollektiven Erinnerns zueinander in Bezug? Wie thematisieren sie Sprache und Mehrsprachigkeit als Teil von Identität, und welche Rolle spielen Familiengenealogien? Ausgehend von den Grundideen eines erweiterten Mittelmeerraums und des Nomadismus als Chiffre unserer Zeit beleuchten die Beiträge des Bandes, wie diese Fragen und Themenfelder im Werk von E. Sevgi Özdamar, S. Stanišić, F. Aydemir, R. Menasse, E. Jelinek, N. Ebrahimi, Franzobel, D. Güçyeter, A. Dardan und anderen behandelt werden.Beiträge von: S. Arnaudova, M. Bobinac, O. Branchina, L. Perrone Capano, N. Igl, M. Latini, W. Müller-Funk, G. C. Pfeiffer, M. Schilirò, A. Schininà, M. P. Scialdone, W. Sievers, E. Nesje Vestli, S. Vlasta.
Link: https://www.artemide-edizioni.it/prodotto/in-movimento/
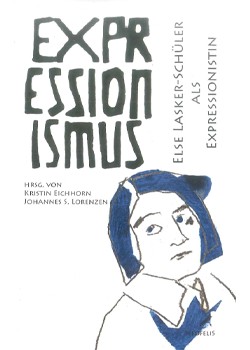
Descrizione: Else Lasker-Schueler (1869-1945) ist nicht nur eine der herausregendsten Autorinnen der ersten Haelfte des 20. Jahrhunderts. Sie ist auch wie keine zweite Dichterin mit dem Expressionismus verbunden, hat sie doch als einzige weibliche Stimme Aufnahme in die beruehmte Anthologie Menschheitsdaemmerung (1919) von Kurt Pinthus gefunden. Anlaesslich ihres 80. Todestags, der gleichzeitig auch das zehnjaehrige Bestehen der Zeitschrift Expressionismus markiert, stellt der Band die als wichtigste Dichterin des Expressionismus schlechthin kanonisierte Autorin in den Mittelpunkt und bietet neue Erkundungen ihres Werks - von dessen Programmatik ueber Fragen von Auffuehrung und Performanz bis hin zu Schreibpraxis und Intermedialitaet. Mit Beitraegen von: Akane Nishioka, Imelda Rohrbacher, Fabiana Paciello, Viviane Hoof, Paula Vosse, Toni Bernhart, Marilisa Reisert, Adrian Renner.
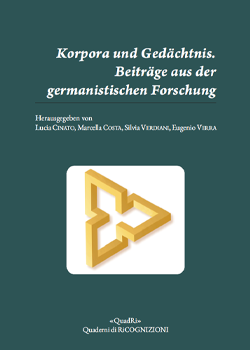
Beschreibung: In diesem Band werden die Vorträge der internationalen Tagung Korpora und Gedächtnis. Beitrage aus der germanistischen Forschung veröffentlicht, die am 17. und 18. November 2022 am Fachbereich für Fremdsprachen, Literaturen und moderne Kulturen der Universität Turin organisiert wurde. Der Band bietet einen interdisziplinären Einblick in die komplexen Wechselwirkungen von Sprache, Orten, Erinnerung und Identitätskonstruktion. Die Beiträge zeichnen sich dadurch aus, dass sie neue theoretische, methodische und anwendungsbezogene Perspektiven eröffnen und dabei unterschiedliche Aspekte der Arbeit mit Datensammlungen mit historischem oder autobiographischem Bezug beleuchten. Die interdisziplinären Methodologien und theoretischen Rahmenkonzepte, die in diesem Band zum Einsatz kommen, tragen wesentlich dazu bei, die Komplexität und Vielschichtigkeit der narrativen Erinnerungsprozesse zu erfassen und bieten gleichzeitig innovative Ansätze für zukünftige Forschungen in den Bereichen angewandter Sprachwissenschaft, Gesprächs- und Diskursanalyse.
Mit Beiträgen von: Lucia Cinato, Marcella Costa, Carolina Flinz, Anne Larrory-Wunder, Simona Leonardi, Rita Luppi, Ramona Pellegrino, Maria Francesca Ponzi, Ricarda Schneider, Silvia Verdiani, Eugenio Verra
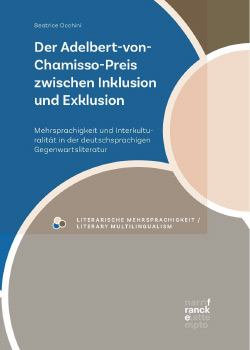
Descrizione: Das Buch untersucht den Literaturpreis Adelbert-von-Chamisso (1985–2017), eine der einflussreichsten sowie kontroversesten Auszeichnungen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, deren kulturpolitische Tragweite weit über den Literaturbereich hinausreicht. Anhand einer Analyse origineller Archivunterlagen und literarischer Werke beleuchtet diese interdisziplinäre Arbeit innovativ die Reaktionsmechanismen des deutschen Kulturraums auf die Herausforderungen der soziokulturellen Transformationen durch Migration und Globalisierung. Die fünf Kapitel widmen sich dem Entstehungskontext, der Geschichte und Struktur des Preises, der Entwicklung und literaturwissenschaftlichen Rezeption der sogenannten ‚Chamisso-Literatur‘ sowie der Poetik zweier Preisträgerinnen, Terézia Mora und Uljana Wolf, als Beispiele für die jüngsten Entwicklungen in der Chamisso-Literatur.
Link: https://www.narr.de/der-adelbert-von-chamisso-preis-zwischen-inklusion-und-exklusion-38775-1/
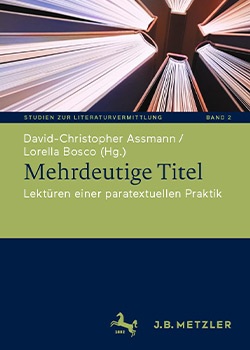
Beschreibung: Gérard Genette zufolge ist die literaturtheoretische Bestimmung des Titels „problematischer als bei den anderen Elementen des Paratextes“. Der Band setzt an dieser Beobachtung an und macht sie für die Untersuchung literarischer Mehrdeutigkeit produktiv. Die Beiträge gehen der Frage nach, inwiefern Titel an peritextuellen Praktiken der Erzeugung, Rezeption und Vermittlung literarischer Mehrdeutigkeit beteiligt sind. Im Zentrum stehen mehrdeutige oder auffallend eindeutige Titel seit dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart: kurze oder lange Titel, semantisch leere, selbstreferentielle oder bemerkenswert intertextuelle Titel, einprägsame oder doppeldeutige Titel, besonders prägnante oder fehlende Titel.
Mit Beiträgen von: Elena Agazzi, David-Christopher Assmann, Lorella Bosco, Giulia A. Disanto, Emilia Fiandra, Christoph Jürgensen, Stefan Tetzlaff, Antonia Villinger, Gerhard Kaiser.
Link: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-69885-3

Link: https://x.com/MolussiaEd/status/1865826914553700444?mx=2

Descrizione: Il volume, che racchiude venticinque saggi, pone al suo centro, come oggetto di rinnovata riflessione, la Mitteleuropa come mito moderno, dai caratteri politicamente sfuggenti ma dal grande fascino culturale. Il costrutto mitteleuropeo, insieme spaziale e simbolico, ha ancora oggi la capacità di porre interrogativi sul rapporto tra centro e periferia imponendo un ripensamento, anche radicale, dei concetti di transculturalità e transnazionalità, dove la componente ebraica appare determinante. Un ripensamento che investe le contraddizioni dell’Europa contemporanea e, in qualche modo, anche del mondo, interrogando forme di identità apparentemente monolitiche, collegate a confini territoriali, linguistici, etnici o religiosi. La prospettiva transnazionale su cui questo volume vuole riflettere si adatta in particolare alle esperienze dei “cittadini di fede mosaica” e invita, anche riguardo a epoche di esacerbato nazionalismo, a esercitare una visione “sovranazionale” in grado di contaminare Oriente e Occidente, universalismo e localismo.

Descrizione: Il volume che raccoglie e traduce una selezione di interviste rilasciate da Carmine Gino Chiellino negli ultimi trent’anni documenta la ricerca pluridecennale del poeta, saggista e romanziere di una lingua del dialogo per realizzare il suo progetto di scrittore interculturale e anche per trasmettere ciò che di innovativo e speciale c'è nella letteratura interculturale europea.
Link: https://www.thelem.de/thelem/essay/83225-chiellino-gespr%C3%A4che/#cc-m-product-10546095885

Descrizione: Gli anni Novanta del Novecento hanno rappresentato un significativo cambiamento culturale in Germania caratterizzato dalla ricerca di una nuova identità nazionale, contrapposta a un’impennata di atti xenofobi contro gli immigrati. In tale contesto, emerge la figura del “turco” nella stampa, in televisione, in letteratura e nel cinema. Autori come Emine Sevgi Özdamar, Zafer Şenocak, Feridun Zaimoğlu e Hatice Akyün contribuiscono a ciò che viene indicato come Turkish turn nella cultura tedesca e promuovono in particolare, attraverso la lingua utilizzata nelle loro opere, una nuova autodefinizione turco-tedesca, sfidando così l’idea di un’identità nazionale omogenea. L’indagine sull’oralità finalizzata a trasmettere l’illusione di autenticità in questi testi è una sfida per chi traduce verso la lingua italiana. Il volume si concentra sull’analisi delle traduzioni pubblicate nel nostro paese. Il quadro teorico di riferimento per l’indagine è il modello di Juliane House per la valutazione della qualità della traduzione, che tiene conto sia della dimensione linguistica sia di quella culturale, senza tralasciare l’importanza della comprensione interculturale nella traduzione. L’autrice propone quindi l’applicazione del modello di House ai testi presi in esame, evidenziando soprattutto le scelte e le soluzioni trovate nella traduzione degli elementi culturospecifici.

Descrizione: Expert-lay communication in the medical field requires the utmost attention to readers’ or listeners’ needs and competences. If these are neglected, laypeople’s comprehension of the message is likely to be negatively affected. Text types like package leaflets and informed consents have been the object of countless studies. In this volume, a new document type, the layperson summary of clinical trials, is examined. The analysis is conducted from a contrastive and translational perspective in three languages (English, German, and Italian) and based on corpus linguistics methods. All texts are instances of interlingual translations of simplified documents written in Plain Language, which represent a still widely unexplored niche within the field of translation studies.

Descrizione: Pubblicati tra il 1969 e il 1978, i saggi di Jean Améry raccolti in questo volume proposto in Germania nel 2024 dall’editore Klett Cotta di Stoccarda ed edito in Italia in occasione della Giornata della memoria 2025 sorprendono per la loro attualità. Nella loro concisa chiarezza e nei temi trattati, essi si leggono come fossero stati scritti oggi. Améry, ebreo laico, costretto a definirsi tale dalle leggi di Norimberga, riflette anzitutto sul suo legame esistenziale con Israele. Un legame che ritiene di condividere con la stragrande maggioranza degli ebrei nel mondo, e che ha ben poco a che fare con l’approvazione incondizionata dei governi israeliani. E che si traduce tuttavia in un interesse profondamente radicato per l'esistenza di questo paese – che egli pur non conosce, di cui non parla la lingua e il cui folklore gli è estraneo. Améry sa, infatti, che ogni volta che la sua vita sarà in pericolo ci sarà un lembo di terra pronto ad accoglierlo, e che finché esisterà Israele egli non potrà essere gettato di nuovo in pasto all'orrore, con il tacito consenso di spettatori più o meno consapevoli.
Link: https://www.bollatiboringhieri.it/libri/jean-amery-il-nuovo-antisemitismo-9788833944081/

Descrizione: Nel 2002 vengono ritrovate in una cantina di Modena due casse di legno contenenti 94 volumi, per la maggior parte in tedesco, editi nei primi decenni del Novecento: il timbro della Delasem (Delegazione per l’assistenza degli emigranti) con riferimento a Villa Emma permette di collegarli con la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi ebrei accolti e salvati a Nonantola durante la Seconda guerra mondiale. I libri provengono infatti da una più ampia biblioteca di cui si è persa traccia dopo l’8 settembre 1943, quando il gruppo dei rifugiati fu costretto a riprendere la fuga. Il ritrovamento di questi libri in fuga ha aperto presso la Fondazione Villa Emma diverse linee di ricerca e progettazione, di cui il presente volume raccoglie parte dei frutti: dal ruolo dei libri in guerra ai destini dei loro autori, dai particolari generi letterari presenti in questo speciale corpus alla scelta dell’educazione come prospettiva di salvezza anche nei tempi più bui, dalla sorte dei libri trafugati dai nazisti fino al libro come presenza simbolica, storica e affettiva in memoriali, monumenti, musei.

Descrizione: Die Metonymie im Deutschen ist bislang sowohl auf theoretischer wie auch auf empirischer Ebene vernachlässigt worden. Bei dieser Forschungslücke setzt das Buch an und befasst sich mit dem deutschsprachigen Migrationsdiskurs. Die Arbeit ist interdisziplinär ausgerichtet und verbindet kognitionstheoretische Ansätze mit einer qualitativen und quantitativen Korpusanalyse von knapp 300 Artikeln aus Bild.de und Spiegel Online. Metonymien sind im Migrationsdiskurs allgegenwärtig, operieren oftmals unbemerkt in ihrer Interaktion mit diskriminierenden metaphorischen Mappings und erscheinen somit im Rahmen von Persuasionsstrategien als besonders effizient. Die Arbeit verfolgt zwei Ziele. Zum einen sollen die sprachspezifischen Realisierungsarten der Metonymie im Deutschen dargelegt werden, dies mit Schwerpunkt auf Konversionsvorgängen und Komposita. Zum anderen soll untersucht werden, wie metonymische Phänomene wesentlich dazu beitragen, stereotype und antimigrantische Vorstellungen zu vermitteln.

Descrizione:Kathrin Rögglas Prosa zählt innerhalb der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zu den weitreichendsten Versuchen, den Realismus neu zu denken. Im Rahmen einer qualitativen Analyse der Stilentwicklung von Rögglas Prosa setzt sich diese Studie mit ihrer Poetik auseinander, um festzustellen, inwieweit Rögglas Schreiben einer ‚Szeno-Graphie‘ der Gegenwart entspricht.
Link: www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783111331140/html#overview

Descrizione: At the convergence of human studies, biocultural and neuroscientific research, this book offers unprecedented insights into the interpretation of literary texts. It presents the neurohermeneutics of suspicion—a bold, innovative approach illuminating the intricate bond between literature and the human mind. Embracing ambiguity as a hallmark of literature, readers are encouraged to adopt a suspicious stance to unearth the complex, multilayered and dynamic nature of literary texts, thereby fully engaging their imagination and their embodied, emotional and imaginative faculties. Our exploration navigates the crossroads of language, thought, culture, and biology, delving into hidden layers of meaning within literary texts. This transformative exploration not only redefines literary scholarship but also offers lay readers a dynamic, immersive reading experience. Ultimately, this book aims to ignite curiosity, suspense, and surprise, transforming the act of reading into a creative and engaging journey through the depths of the human mind and aesthetic experiences
Link: https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-0364-0760-5

Descrizione: Capolavoro di Franz Kafka, il racconto della metamorfosi di un borghese qualunque in uno scarafaggio non risparmia né orrore né angoscia al suo protagonista, e ai lettori. Le descrizioni minuziose e quasi asettiche del gigantesco insetto, con la sua corazza dura e scura e le zampette sgambettanti, dominano fin dalle prime pagine: al commesso viaggiatore Gregor Samsa, straniante alter ego dell’autore, dopo la trasformazione non resta che fare i conti con l’indifferenza che attorno a lui si fa sempre più profonda, persino nella sua stessa famiglia. A questa angosciosa solitudine tipicamente novecentesca fanno eco in questa edizione illustrata una serie di opere scelte di Egon Schiele, dai celebri autoritratti ai panorami desolanti alle sue più tipiche nature morte. Kafka e Schiele ci parlano di un impellente bisogno di liberarsi, dai propri drammi personali e dagli schemi insensati della vita borghese: come leggiamo nell’introduzione di Giulio Schiavoni, il pittore austriaco condivise con Kafka «la riflessione sul corpo e sulla sua nudità: ai corpi contorti ed esasperati, debilitati ed emaciati o addirittura mutilati tratteggiati da Schiele, si può affiancare agevolmente anche la vicenda estrema di Gregor Samsa, incentrata su un corpo di cui liberarsi e di cui fare a meno». Per entrambi l’isolamento, il dolore, lo straniamento sono condizioni forse intrinseche nella miseria umana, e l’arte diventa un luogo in cui trasformarsi e vedere così più chiaramente la realtà e se stessi.

Descrizione: Das Buch beschäftigt sich mit der Interaktion von Fremdsprachenlehrenden in internationalen Videokonferenzen, die im Rahmen einer Lehrendenbildungsmaßnahme stattgefunden haben. Mittels einer multimodalen Interaktionsanalyse werden der Aufbau und die Moderation in diesen Gesprächen, das Erteilen und Rezipieren positiven und negativen Feedbacks unter den Lehrenden und die Bedeutung beruflicher sowie nationaler Kategorien herausgearbeitet. Ziel der Veröffentlichung ist es, einen Beitrag zur empirischen Forschung in der fremdsprachlichen Lehrendenbildung zu leisten. Damit richtet sich das Buch sowohl an Wissenschaftler:innen, da es methodisch wie inhaltlich zahlreiche Anknüpfungspunkte für weitere Forschung bietet, als auch an Fortbildner:innen und Lehrende, die sich an den darin enthaltenen Erkenntnissen orientieren können.
Link: https://www.narr.de/internationale-videokonferenzen-in-der-lehrendenbildung-1300-1/